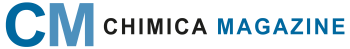07-11-2023
Di Enzo Baglieri, Associate Dean, SDA Bocconi School of Management
Di Enzo Baglieri, Associate Dean, SDA Bocconi School of Management
I miei editoriali sollecitano talvolta dei dibattiti interessanti, che prendono vita in particolare su un social network in cui, ogni mese, posto il link alla versione online della rivista. Alcuni dei miei follower proseguono poi il confronto privatamente con me, sempre a mezzo virtuale, e da parecchi di questi interessanti interlocuzioni sono giunto alla conclusione che della sostenibilità si ignorano in primo luogo in maniera diffusa i principi teorici essenziali. E ho quindi deciso di prendere ispirazione dal capitolo di un mio caro amico e collega, il prof. Stefano Pogutz, che in un libro recente a mia cura, illustra i principi della sostenibilità e il significato di leadership responsabile (Per chi fosse desideroso di approfondimento suggerisco quindi “Manager del Futuro”, a cura di Enzo Baglieri, Egea 2022, Capitolo 1. S. Pogutz, Leadership e sostenibilità).
La sostenibilità è, come anticipo nel titolo, un concetto matematico. E, conseguentemente, sebbene teorie fantasiose, prezzolate ed opportunisticamente negazioniste tentino di sostenere il contrario, non è un’opinione. Vediamone i numeri essenziali.
Dieci. La questione ambientale è da oltre dieci anni, puntualmente a gennaio, protagonista delle preoccupazioni degli esperti presenti ai World Economic Forum di Davos, insieme con rischi contingenti come le pandemie, la ripresa economica e la cyber security.
Ventotto. Sebbene l’espressione sviluppo sostenibile sia stata coniata nel 1987 dalla Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo (Commissione Bruntland) delle Nazioni Unite, ci sono voluti ventotto anni perchè, nel 2015, le Nazioni Unite varassero un programma globale chiamato Agenda 2030 articolato in 17 obiettivi, i Sustainable Development Goals, corrispondenti a specifiche aree di intervento – dalla lotta alla povertà alla parità di genere, dalla questione climatica all’istruzione, dalla vita sulla terra al tema della salute.
Zero. I risultati raggiunti in oltre 35 anni di trattati, politiche e piani di azione si sono mostrati solo marginali, per non dire fallimentari. Il nulla, lo zero assoluto. Infatti, l’analisi dei principali indicatori di sostenibilità sottolinea come, non solo non si sia ancora riusciti a cambiare la nostra traiettoria invertendo la rotta; ma come, purtroppo, in molti casi – ad esempio, la questione climatica, la giustizia sociale, i diritti umani, le biodiversità – le condizioni siano peggiorate portandoci verso una situazione di vera e propria emergenza ecologica, a cui si associano rischi di forte instabilità e incertezza per il nostro benessere.
Nove. Gli scienziati ci dicono che siamo entrati nell’Antropocene, espressione che indica una nuova era geologica in cui l’uomo e le sue attività stanno modificando le dinamiche dei sistemi che regolano la stabilità della nostra biosfera, fino a condizionare la stessa geologia del pianeta. A partire dal 2009, Joan Rockström alla guida di un prestigioso gruppo di ricercatori internazionale, ha proposto un nuovo modello per analizzare e interpretare le conseguenze di queste pressioni, proponendo i cosiddetti planetary boundaries, nove sistemi tra loro interconnessi e interdipendenti le cui dinamiche sono non lineari, complesse e non deterministiche, incerte. Antropocene e planetary boundaries richiedono una nuova consapevolezza, e ci impongono di adottare un nuovo approccio olistico, basato sull’accettazione della complessità come condizione intrinseca, e sul riconoscimento delle proprietà specifiche dei sistemi complessi adattivi. In altre parole, le grandi questioni ambientali e sociali non si possono gestire e risolvere tramite una logica riduzionista, frammentata, isolando le singole cause o cercando singole soluzioni.
Tre. Le condizioni che regolano le logiche manageriali e finanziarie tuttavia, sono proprio all’apposto della visione espressa precedentemente. Efficienza, produttività e massimizzazione di un unico obiettivo, il profitto o più elegantemente il valore creato, sono i tre elementi della visione riduzionista dominante, che tende a risolvere il tema della gestione della complessità proponendo in modo semplicistico l’idea che sia sempre possibile trovare soluzioni che generano valore per tutti gli stakeholder coinvolti. Lo stesso riferimento alle dimensioni people e planet insieme con il tradizionale profit sembra suggerire la possibilità di soluzioni semplice e win-win-win.
Nella realtà, invece, la sostenibilità pone davanti al decisore situazioni in cui non ci può essere una semplice armonizzazione tra dimensione economica, ambientale e sociale. Un risultato positivo in un’area della sostenibilità deve essere bilanciato da una potenziale “perdita”, o da un minore beneficio, in un’altra area. Da ciò nasce la necessità di analizzare le conseguenze delle decisioni, soppesando le implicazioni e tenendo in considerazione le molteplici interazioni tra i sistemi in cui si opera, con la consapevolezza che questo mondo è regolato dai trade-off.
La consapevolezza non ha però lo scopo di frustrare la nostra legittima ricerca di condizioni migliori di vita e di benessere economico e sociale. Deve piuttosto metterci nella condizione di produrre risposte che soppesino nella maniera opportuna quale beneficio vale la pena preservare e quale rinuncia dobbiamo accettare. Finché non avremo adottato questa diversa prospettiva, la sostenibilità, anche nella logistica, rimarrà solo un proclama e la classe dirigente di questo secolo dovrà rendere conto ai suoi figli dell’eredità disastrosa che lascerà. Io, che sono un inguaribile ottimista, credo ci si possa riuscire, anche grazie alla forza della competenza che ci arriva dall’istruzione e dal contributo che la nostra rivista può fornire per creare una coscienza diffusa del tema nella disciplina e nelle professionalità del supply chain management.
La sostenibilità è, come anticipo nel titolo, un concetto matematico. E, conseguentemente, sebbene teorie fantasiose, prezzolate ed opportunisticamente negazioniste tentino di sostenere il contrario, non è un’opinione. Vediamone i numeri essenziali.
Dieci. La questione ambientale è da oltre dieci anni, puntualmente a gennaio, protagonista delle preoccupazioni degli esperti presenti ai World Economic Forum di Davos, insieme con rischi contingenti come le pandemie, la ripresa economica e la cyber security.
Ventotto. Sebbene l’espressione sviluppo sostenibile sia stata coniata nel 1987 dalla Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo (Commissione Bruntland) delle Nazioni Unite, ci sono voluti ventotto anni perchè, nel 2015, le Nazioni Unite varassero un programma globale chiamato Agenda 2030 articolato in 17 obiettivi, i Sustainable Development Goals, corrispondenti a specifiche aree di intervento – dalla lotta alla povertà alla parità di genere, dalla questione climatica all’istruzione, dalla vita sulla terra al tema della salute.
Zero. I risultati raggiunti in oltre 35 anni di trattati, politiche e piani di azione si sono mostrati solo marginali, per non dire fallimentari. Il nulla, lo zero assoluto. Infatti, l’analisi dei principali indicatori di sostenibilità sottolinea come, non solo non si sia ancora riusciti a cambiare la nostra traiettoria invertendo la rotta; ma come, purtroppo, in molti casi – ad esempio, la questione climatica, la giustizia sociale, i diritti umani, le biodiversità – le condizioni siano peggiorate portandoci verso una situazione di vera e propria emergenza ecologica, a cui si associano rischi di forte instabilità e incertezza per il nostro benessere.
Nove. Gli scienziati ci dicono che siamo entrati nell’Antropocene, espressione che indica una nuova era geologica in cui l’uomo e le sue attività stanno modificando le dinamiche dei sistemi che regolano la stabilità della nostra biosfera, fino a condizionare la stessa geologia del pianeta. A partire dal 2009, Joan Rockström alla guida di un prestigioso gruppo di ricercatori internazionale, ha proposto un nuovo modello per analizzare e interpretare le conseguenze di queste pressioni, proponendo i cosiddetti planetary boundaries, nove sistemi tra loro interconnessi e interdipendenti le cui dinamiche sono non lineari, complesse e non deterministiche, incerte. Antropocene e planetary boundaries richiedono una nuova consapevolezza, e ci impongono di adottare un nuovo approccio olistico, basato sull’accettazione della complessità come condizione intrinseca, e sul riconoscimento delle proprietà specifiche dei sistemi complessi adattivi. In altre parole, le grandi questioni ambientali e sociali non si possono gestire e risolvere tramite una logica riduzionista, frammentata, isolando le singole cause o cercando singole soluzioni.
Tre. Le condizioni che regolano le logiche manageriali e finanziarie tuttavia, sono proprio all’apposto della visione espressa precedentemente. Efficienza, produttività e massimizzazione di un unico obiettivo, il profitto o più elegantemente il valore creato, sono i tre elementi della visione riduzionista dominante, che tende a risolvere il tema della gestione della complessità proponendo in modo semplicistico l’idea che sia sempre possibile trovare soluzioni che generano valore per tutti gli stakeholder coinvolti. Lo stesso riferimento alle dimensioni people e planet insieme con il tradizionale profit sembra suggerire la possibilità di soluzioni semplice e win-win-win.
Nella realtà, invece, la sostenibilità pone davanti al decisore situazioni in cui non ci può essere una semplice armonizzazione tra dimensione economica, ambientale e sociale. Un risultato positivo in un’area della sostenibilità deve essere bilanciato da una potenziale “perdita”, o da un minore beneficio, in un’altra area. Da ciò nasce la necessità di analizzare le conseguenze delle decisioni, soppesando le implicazioni e tenendo in considerazione le molteplici interazioni tra i sistemi in cui si opera, con la consapevolezza che questo mondo è regolato dai trade-off.
La consapevolezza non ha però lo scopo di frustrare la nostra legittima ricerca di condizioni migliori di vita e di benessere economico e sociale. Deve piuttosto metterci nella condizione di produrre risposte che soppesino nella maniera opportuna quale beneficio vale la pena preservare e quale rinuncia dobbiamo accettare. Finché non avremo adottato questa diversa prospettiva, la sostenibilità, anche nella logistica, rimarrà solo un proclama e la classe dirigente di questo secolo dovrà rendere conto ai suoi figli dell’eredità disastrosa che lascerà. Io, che sono un inguaribile ottimista, credo ci si possa riuscire, anche grazie alla forza della competenza che ci arriva dall’istruzione e dal contributo che la nostra rivista può fornire per creare una coscienza diffusa del tema nella disciplina e nelle professionalità del supply chain management.