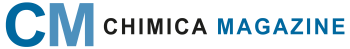28-12-2023
Di Enzo Baglieri, Associate Dean, SDA Bocconi School of Management
Di Enzo Baglieri, Associate Dean, SDA Bocconi School of Management
L’ultimo editoriale dell’anno è per me sempre il più complesso. Vorrei, da un lato, fare un bilancio di quanto è accaduto nell’anno che si avvia al termine, dall’altro avrei piacere a gettare lo sguardo oltre l’orizzonte e magari trasmettere il messaggio positivo che sempre ci aspettiamo in questi momenti della nostra esistenza. Poi la realtà prende il sopravvento e mi rifletto sul fatto che i bilanci, anche nella mia disciplina, sono una fotografia che descrive solo parzialmente quello che davvero accade, perché per farla aggiustiamo le luci, trucchiamo il soggetto, aggiustiamo la scena e ne viene fuori un’immagine statica di qualcosa che invece è in continuo divenire. E così allora opto sempre per l’opzione che più mi è congeniale, ossia parlare del futuro. Non di quello che accadrà, perché non sono in grado di prevederlo, ma del o dei futuri plausibili.
Il 2024 si annuncia infatti come un anno pieno di importanti avvenimenti che dalla politica influenzeranno l’economia e di conseguenza le decisioni di management, di tanti di voi. Proviamo insieme a illustrare la triade magica che mi sembra più opportuna discutere su queste pagine.
In primo luogo sarà un anno di importanti eventi elettorali. Alcuni scontati, come il rinnovo della presidenza in Russia. Alcuni molto incerti, come le presidenziali americane, io cui si profila un duello Biden – Trump, che può riservare delle sorprese. E in mezzo, le elezioni europee, in cui si profila come certa una vittoria delle posizioni di centro-destra e su cui però non è irrilevante capire quanto peserà il centro e quanto le destre più radicali. A ogni modo, la sintesi essenziale di questa prima parte del futuro plausibile a breve è che il 2024 si profila come un anno di interlocuzione, nell’attesa che si chiariscano le posizioni dominanti nello scacchiere globale e le politiche che ciascuna parte vorrà adottare.
In secondo luogo, come avrete notato, questa fine di anno 2023 si dimostra particolarmente interessante sul fronte dell’andamento del mercato borsistico. Un osservatore non esperto potrebbe interrogarsi sull’anomalia di questi rendimenti così elevati a fronte di due guerre che si stanno svolgendo in parallelo mentre scrivo e sicuramente andranno a lungo avanti e di questa sostanziale sospensione determinata dalle incertezze elettorali di cui sopra. Ebbene, l’unica spiegazione plausibile è l’attesa della svolta nel ciclo economico, rallentata nel 2023 dal fenomeno inflattivo. Come noto, ci si aspettava un 2023 più frizzante e di maggiore crescita, adesso queste speranze sono riposte nel 2024. Non sono in grado di dire quanto ci sia di credibile in queste aspettative, ma le Borse speculano sulle prospettive e scontano nei prezzi queste dinamiche in anticipo. In particolare, ovviamente, molto dipende dal comportamento delle banche centrali, che di fronte a una riduzione dell’inflazione potrebbero attenuare le loro politiche di rigidità e favorire quindi un ammorbidimento dei tassi d’interesse. In sintesi, ancora volatilità nella prima parte del 2024, ma con la prospettiva che le condizioni dalla seconda metà dell’anno favoriscano una buona ripresa generalizzata dell’economia.
Infine, il tema delle catene del valore globali. Come noto, è sempre più marcata la presa di distanza dell’economia “occidentale” da quella “orientale”. Dopo anni di commercio internazionale libero, di globalizzazione e di supply chain fortemente dipendenti dai Paesi del Far East, dalla pandemia in avanti, i governi, e in particolare quello americano, ancora di più nella Presidenza Biden, stanno portando avanti la politica del derisking. Il termine sostituisce il precedente decoupling (che suonava troppo di “divorzio”) e consiste di una strategia più limitata, fatta di operazioni chirurgiche, finalizzate a decidere in quali settori mitigare la vulnerabilità delle nostre economie che consegue dalla dipendenza dalla Cina. Il tema centrale del dibattito è quindi decidere quali supply chain mantenere globali e per quali invece favorire il re-shoring o più probabilmente il near-shoring. La questione delicata per l’economia italiana è proprio nella natura dei settori industriali che più ci caratterizzano. Il settore della moda e del lusso non presenta questa sostanziale delicatezza per le economie mondiali e quindi su queste industrie le catene del valore rimarranno ragionevolmente ancora dipendenti dai flussi e dalle produzioni orientali. Tradotto: una guerra commerciale con la Cina potrebbe inginocchiare una parte importante della nostra economia, ma non essere considerato un grave problema per la vulnerabilità delle grandi economie e politiche globali. Diverso il caso per le industrie ad alto contenuto tecnologico, come i semiconduttori, le batterie, i pannelli solari e le tecnologie con applicazioni militari, in cui abbiamo già osservato l’effetto della carenza di approvvigionamenti dal Far East e che in virtù proprio dell’essenzialità strategica dei relativi settori rappresentano le aree su cui focalizzare le azioni protettive. L’Italia, come noto, proprio in questi giorni ha abbandonato il percorso intrapreso con l’adesione alla cosiddetta “nuova Via della Seta”. Era stata un’anomalia l’ingresso a suo tempo, non ha prodotto alcun risultato concreto per la nostra economia nel mentre, ci ha esposto a una serie di critiche da parte delle economie a cui più siamo legati e costituisce un’anomalia anche adesso l’uscita dall’accordo. Tuttavia la riflessione deve essere a mio personale modo di vedere impostata in modo totalmente diverso. Il rischio, in generale, non è la conseguenza della dipendenza dalla Cina, ma dipendere in generale. Per il nostro Paese, privo di risorse e di materie prime, il derisking richiede quindi una prospettiva che nel mondo del procurement chiameremmo di multiple o almeno di parallel sourcing. Ossia, non si può dipendere da un solo fornitore, a prescindere, chiunque esso sia, ma bisogna costruire relazioni stabili e direi collaborative con almeno due e forse più fonti di approvvigionamento. A livello politico è meno semplice, a livello aziendale è la lezione che ci portiamo a casa dopo.
Tirando le somme di queste macro-forze che determineranno lo sviluppo economico e politico del prossimo anno, che cosa possiamo concretamente immaginare sulle nostre aziende e sulle nostre supply chain? Direi che tre sono le direzioni da perseguire.
La prima: non abbandonare quanto avviato sinora sul tema della sostenibilità. Può essere un fattore distintivo per le nostre produzioni, ci consente di ridurre la rischiosità della dipendenza da alcuni mercati della fornitura e abbassa i costi energetici delle aziende.
La seconda: pianificare investimenti in tecnologia. Se le dinamiche saranno confermate, nella seconda parte dell’anno potremo tornare con maggiore facilità all’utilizzo del debito e ci servono mezzi e soluzioni per ridare competitività a settori che stanno cominciando a soffrire per la rinuncia in questi anni all’innovazione.
La terza: guardare con maggiore coraggio al mercato americano. Il derisking comporta anche una quantità di risorse finanziare inimmaginabili per l’economia italiana destinate a sostenere tanti settori, in particolare quelli in cui la nostra sapienza produttiva è ancora differenziale.
Il 2024 si annuncia infatti come un anno pieno di importanti avvenimenti che dalla politica influenzeranno l’economia e di conseguenza le decisioni di management, di tanti di voi. Proviamo insieme a illustrare la triade magica che mi sembra più opportuna discutere su queste pagine.
In primo luogo sarà un anno di importanti eventi elettorali. Alcuni scontati, come il rinnovo della presidenza in Russia. Alcuni molto incerti, come le presidenziali americane, io cui si profila un duello Biden – Trump, che può riservare delle sorprese. E in mezzo, le elezioni europee, in cui si profila come certa una vittoria delle posizioni di centro-destra e su cui però non è irrilevante capire quanto peserà il centro e quanto le destre più radicali. A ogni modo, la sintesi essenziale di questa prima parte del futuro plausibile a breve è che il 2024 si profila come un anno di interlocuzione, nell’attesa che si chiariscano le posizioni dominanti nello scacchiere globale e le politiche che ciascuna parte vorrà adottare.
In secondo luogo, come avrete notato, questa fine di anno 2023 si dimostra particolarmente interessante sul fronte dell’andamento del mercato borsistico. Un osservatore non esperto potrebbe interrogarsi sull’anomalia di questi rendimenti così elevati a fronte di due guerre che si stanno svolgendo in parallelo mentre scrivo e sicuramente andranno a lungo avanti e di questa sostanziale sospensione determinata dalle incertezze elettorali di cui sopra. Ebbene, l’unica spiegazione plausibile è l’attesa della svolta nel ciclo economico, rallentata nel 2023 dal fenomeno inflattivo. Come noto, ci si aspettava un 2023 più frizzante e di maggiore crescita, adesso queste speranze sono riposte nel 2024. Non sono in grado di dire quanto ci sia di credibile in queste aspettative, ma le Borse speculano sulle prospettive e scontano nei prezzi queste dinamiche in anticipo. In particolare, ovviamente, molto dipende dal comportamento delle banche centrali, che di fronte a una riduzione dell’inflazione potrebbero attenuare le loro politiche di rigidità e favorire quindi un ammorbidimento dei tassi d’interesse. In sintesi, ancora volatilità nella prima parte del 2024, ma con la prospettiva che le condizioni dalla seconda metà dell’anno favoriscano una buona ripresa generalizzata dell’economia.
Infine, il tema delle catene del valore globali. Come noto, è sempre più marcata la presa di distanza dell’economia “occidentale” da quella “orientale”. Dopo anni di commercio internazionale libero, di globalizzazione e di supply chain fortemente dipendenti dai Paesi del Far East, dalla pandemia in avanti, i governi, e in particolare quello americano, ancora di più nella Presidenza Biden, stanno portando avanti la politica del derisking. Il termine sostituisce il precedente decoupling (che suonava troppo di “divorzio”) e consiste di una strategia più limitata, fatta di operazioni chirurgiche, finalizzate a decidere in quali settori mitigare la vulnerabilità delle nostre economie che consegue dalla dipendenza dalla Cina. Il tema centrale del dibattito è quindi decidere quali supply chain mantenere globali e per quali invece favorire il re-shoring o più probabilmente il near-shoring. La questione delicata per l’economia italiana è proprio nella natura dei settori industriali che più ci caratterizzano. Il settore della moda e del lusso non presenta questa sostanziale delicatezza per le economie mondiali e quindi su queste industrie le catene del valore rimarranno ragionevolmente ancora dipendenti dai flussi e dalle produzioni orientali. Tradotto: una guerra commerciale con la Cina potrebbe inginocchiare una parte importante della nostra economia, ma non essere considerato un grave problema per la vulnerabilità delle grandi economie e politiche globali. Diverso il caso per le industrie ad alto contenuto tecnologico, come i semiconduttori, le batterie, i pannelli solari e le tecnologie con applicazioni militari, in cui abbiamo già osservato l’effetto della carenza di approvvigionamenti dal Far East e che in virtù proprio dell’essenzialità strategica dei relativi settori rappresentano le aree su cui focalizzare le azioni protettive. L’Italia, come noto, proprio in questi giorni ha abbandonato il percorso intrapreso con l’adesione alla cosiddetta “nuova Via della Seta”. Era stata un’anomalia l’ingresso a suo tempo, non ha prodotto alcun risultato concreto per la nostra economia nel mentre, ci ha esposto a una serie di critiche da parte delle economie a cui più siamo legati e costituisce un’anomalia anche adesso l’uscita dall’accordo. Tuttavia la riflessione deve essere a mio personale modo di vedere impostata in modo totalmente diverso. Il rischio, in generale, non è la conseguenza della dipendenza dalla Cina, ma dipendere in generale. Per il nostro Paese, privo di risorse e di materie prime, il derisking richiede quindi una prospettiva che nel mondo del procurement chiameremmo di multiple o almeno di parallel sourcing. Ossia, non si può dipendere da un solo fornitore, a prescindere, chiunque esso sia, ma bisogna costruire relazioni stabili e direi collaborative con almeno due e forse più fonti di approvvigionamento. A livello politico è meno semplice, a livello aziendale è la lezione che ci portiamo a casa dopo.
Tirando le somme di queste macro-forze che determineranno lo sviluppo economico e politico del prossimo anno, che cosa possiamo concretamente immaginare sulle nostre aziende e sulle nostre supply chain? Direi che tre sono le direzioni da perseguire.
La prima: non abbandonare quanto avviato sinora sul tema della sostenibilità. Può essere un fattore distintivo per le nostre produzioni, ci consente di ridurre la rischiosità della dipendenza da alcuni mercati della fornitura e abbassa i costi energetici delle aziende.
La seconda: pianificare investimenti in tecnologia. Se le dinamiche saranno confermate, nella seconda parte dell’anno potremo tornare con maggiore facilità all’utilizzo del debito e ci servono mezzi e soluzioni per ridare competitività a settori che stanno cominciando a soffrire per la rinuncia in questi anni all’innovazione.
La terza: guardare con maggiore coraggio al mercato americano. Il derisking comporta anche una quantità di risorse finanziare inimmaginabili per l’economia italiana destinate a sostenere tanti settori, in particolare quelli in cui la nostra sapienza produttiva è ancora differenziale.