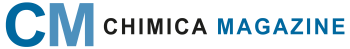04-03-2024
di Enzo Baglieri, Associate Dean, SDA Bocconi School of Management
di Enzo Baglieri, Associate Dean, SDA Bocconi School of Management
Agli inizi di gennaio di quest’anno, tra un avanzo di cenone e una sessione di tombola in famiglia, una notizia ha attirato la mia attenzione: Hyperloop One avrebbe cominciato a cedere i suoi asset, avrebbe chiuso gli uffici di Los Angeles e avrebbe licenziato la maggioranza dei suoi dipendenti. La notizia è riportata da numerosi organi di stampa, che riprendono una notizia pubblicata da Bloomberg e basata su una fonte interna anonima, ma non risulta smentita dall’azienda stessa, il cui sito web è tuttavia introvabile. Sulla piattaforma Reddit, molti post segnalano proprio l’improvvisa scomparsa di ogni comunicazione intorno all’azienda in oggetto, sebbene ancora la tecnologia appaia di interesse per molti operatori, tra cui una concorrente con base a Tolosa, Hyperloop TT, con cui collaborano aziende leader nel mondo delle tecnologie ferroviarie, come Hitachi, e che avrebbe stipulato in Italia un accordo con il consorzio costituito da Leonardo e WeBuild, che si è aggiudicato la gara delle Concessioni Autostradali Venete, in Italia, per la sperimentazione nel Nord Est del nostro Paese della tecnologia del treno supersonico a bassa pressione.
Hyperloop Technologies Inc., poi Hyperloop One, nasce nel 2014. Sebbene in molti siano convinti che si tratti di una delle start up di Elon Musk, a giugno del 2015 Space X ha smentito ufficialmente che Space X o il signor Elon Musk siano mai stati affiliati al progetto, sebbene la stessa Space X avesse dichiarato di voler costruire un tratto sperimentale di un miglio per una propria tecnologia hyperloop nella cittadina di Hawthorne, in California. L’associazione diffusa tra l’azienda e Musk deriva dal fatto che i fondatori hanno sin dall’inizio della loro impresa di essersi ispirati a un white paper del 2013 proprio di Elon Musk, che in una delle sue visioni del futuro del mondo, sosteneva che treni a velocità supersonica avrebbero potuto risolvere i problemi della logistica di merci e persone della California.
La tecnologia hyperloop non è un’idea solo americana e non è nuova. Penso possa interessare il lettore scoprire che una delle prime sperimentazioni, con tanto di collaudo di un treno ad alta velocità, è stata realizzata nel 1967 in Sicilia, presso l’aeroporto militare di Trapani-Milo, dove oggi si trova la base dell’Agenzia Spaziale Italiana “Luigi Broglio”. A ogni modo, la start up riuscì nella sua prima fase, secondo Pitchbook, a raccogliere 450 milioni di dollari. Tra gli investitori, anche Richard Branson, tant’è che per un certo periodo l’azienda si è chiamata Virgin Hyperloop. A parte qualche sperimentazione non particolarmente esaltante, l’azienda si è distinta in particolare per le accuse di molestie verso un co-fondatore e un arresto di un manager a Mosca per frode. A fronte di questo, come Bloomberg stesso conferma, nessun contratto è mai stato siglato per la realizzazione di una tratta ferroviaria.
La fine del progetto Hyperloop One non decreta tuttavia necessariamente il declino della tecnologia, ma impone almeno tre riflessioni.
La prima concerne l’ecosistema americano dell’innovazione. Dubito che chi ha contribuito a investire parte dell’iniziale mezzo miliardo di dollari dieci anni fa sia oggi soddisfatto dell’esito dell’iniziativa, ma questo non impedisce allo stesso sistema di finanziamento dell’innovazione e delle start up statunitensi di continuare a sostenere progetti tecnologicamente rivoluzionari e dirompenti sul mercato. Di sicuro tornerò su questo tema nello spazio mensile che la rivista mi concede, perché l’economia di questo Paese e del nostro (Vecchio) Continente non può pensare di sostenere la competitività della propria industria nel futuro prossimo senza dei meccanismi che ci consentano rapidamente di scalare la taglia dell’investimento in progetti innovativi, come accade da 50 anni negli USA e come altrettanto si verifica adesso in Cina.
La seconda riflessione riguarda l’utilità della velocità. Chi sa di logistica, come tutti i lettori, conosce la differenza tra tempestività e puntualità ed è consapevole del fatto che, a meno di categorie e promesse di prestazione molto specifiche, il vero obiettivo della logistica delle merci e delle persone, in Italia come all’estero, non è tanto essere super veloce, ma essere affidabile nella promessa di prestazione, perché l’affidabilità e la puntualità della logistica consentono di dimensionare in maniera opportuna i magazzini, la produzione e anche il livello di servizio promesso al mercato. Come sanno benissimo anche gli operatori economici che tra Los Angeles e San Francisco devono quotidianamente percorrere su gomma tratti di quei 614 km che collegano le due città, con tempi di percorrenza ogni giorno variabili, su una delle Interstate più trafficate degli Stati Uniti, perché non solo non esiste la nostra alta velocità, ma nemmeno un collegamento ferroviario degno di essere preso in considerazione per chi ha esigenze logistiche elementari.
La terza riflessione è conseguente alla precedente. La mia perplessità non è tanto legata alla tecnologia, perché non ho competenze specifiche e non mi permetto quindi di discutere dei rischi legati alla velocità del treno in un tubo isolato a bassa pressione, dei costi della manutenzione, dei problemi legati alla sicurezza dei passeggeri e delle merci, che ho letto agitano molti esperti del settore. Mi lascia invece molto dubbioso un progetto, come quello di cui leggo appunto gli annunci sulla stampa, in un Paese in cui il problema delle infrastrutture ferroviarie è ancora in larga parte la sicurezza, il divario Nord-Sud e l’inadeguatezza del servizio rispetto ai fabbisogni di trasporto di merci e persone. E in cui ancora il vero problema delle infrastrutture sono i costi inspiegabilmente maggiori che in altri Paesi. Ricordo ai lettori che in Italia il costo al kilometro dell’alta velocità era nel 2018, secondo la Corte dei Conti europea, doppio rispetto a qualunque altro Paese dell’Unione. Addirittura nel primo rapporto della Commissione Europea sulla Corruzione in EU, nel 2014, si sosteneva che i costi eccessivi dell’alta velocità in Italia (6 volte superiore al Giappone, per esempio, al tempo) non potevano essere spiegati con le peculiarità geo-morfologiche e sismiche del nostro territorio, ma, anche “alla luce di altri indicatori, di un’eventuale cattiva gestione o di irregolarità delle gare per gli appalti pubblici”. In breve, il problema di questo Paese non è fare andare i treni a velocità supersonica, ma realizzare una rete infrastrutturale veloce e affidabile senza ruberie e malaffare.
Il vero paradosso del fallimento di Hyperloop One, dunque, non è che negli States o in Italia si finanzino tecnologie rivoluzionarie (e inutili mega-strutture), ma che ancora si facciano passi incerti e spesso falsi verso reti infrastrutturali moderne ed efficienti.
Hyperloop Technologies Inc., poi Hyperloop One, nasce nel 2014. Sebbene in molti siano convinti che si tratti di una delle start up di Elon Musk, a giugno del 2015 Space X ha smentito ufficialmente che Space X o il signor Elon Musk siano mai stati affiliati al progetto, sebbene la stessa Space X avesse dichiarato di voler costruire un tratto sperimentale di un miglio per una propria tecnologia hyperloop nella cittadina di Hawthorne, in California. L’associazione diffusa tra l’azienda e Musk deriva dal fatto che i fondatori hanno sin dall’inizio della loro impresa di essersi ispirati a un white paper del 2013 proprio di Elon Musk, che in una delle sue visioni del futuro del mondo, sosteneva che treni a velocità supersonica avrebbero potuto risolvere i problemi della logistica di merci e persone della California.
La tecnologia hyperloop non è un’idea solo americana e non è nuova. Penso possa interessare il lettore scoprire che una delle prime sperimentazioni, con tanto di collaudo di un treno ad alta velocità, è stata realizzata nel 1967 in Sicilia, presso l’aeroporto militare di Trapani-Milo, dove oggi si trova la base dell’Agenzia Spaziale Italiana “Luigi Broglio”. A ogni modo, la start up riuscì nella sua prima fase, secondo Pitchbook, a raccogliere 450 milioni di dollari. Tra gli investitori, anche Richard Branson, tant’è che per un certo periodo l’azienda si è chiamata Virgin Hyperloop. A parte qualche sperimentazione non particolarmente esaltante, l’azienda si è distinta in particolare per le accuse di molestie verso un co-fondatore e un arresto di un manager a Mosca per frode. A fronte di questo, come Bloomberg stesso conferma, nessun contratto è mai stato siglato per la realizzazione di una tratta ferroviaria.
La fine del progetto Hyperloop One non decreta tuttavia necessariamente il declino della tecnologia, ma impone almeno tre riflessioni.
La prima concerne l’ecosistema americano dell’innovazione. Dubito che chi ha contribuito a investire parte dell’iniziale mezzo miliardo di dollari dieci anni fa sia oggi soddisfatto dell’esito dell’iniziativa, ma questo non impedisce allo stesso sistema di finanziamento dell’innovazione e delle start up statunitensi di continuare a sostenere progetti tecnologicamente rivoluzionari e dirompenti sul mercato. Di sicuro tornerò su questo tema nello spazio mensile che la rivista mi concede, perché l’economia di questo Paese e del nostro (Vecchio) Continente non può pensare di sostenere la competitività della propria industria nel futuro prossimo senza dei meccanismi che ci consentano rapidamente di scalare la taglia dell’investimento in progetti innovativi, come accade da 50 anni negli USA e come altrettanto si verifica adesso in Cina.
La seconda riflessione riguarda l’utilità della velocità. Chi sa di logistica, come tutti i lettori, conosce la differenza tra tempestività e puntualità ed è consapevole del fatto che, a meno di categorie e promesse di prestazione molto specifiche, il vero obiettivo della logistica delle merci e delle persone, in Italia come all’estero, non è tanto essere super veloce, ma essere affidabile nella promessa di prestazione, perché l’affidabilità e la puntualità della logistica consentono di dimensionare in maniera opportuna i magazzini, la produzione e anche il livello di servizio promesso al mercato. Come sanno benissimo anche gli operatori economici che tra Los Angeles e San Francisco devono quotidianamente percorrere su gomma tratti di quei 614 km che collegano le due città, con tempi di percorrenza ogni giorno variabili, su una delle Interstate più trafficate degli Stati Uniti, perché non solo non esiste la nostra alta velocità, ma nemmeno un collegamento ferroviario degno di essere preso in considerazione per chi ha esigenze logistiche elementari.
La terza riflessione è conseguente alla precedente. La mia perplessità non è tanto legata alla tecnologia, perché non ho competenze specifiche e non mi permetto quindi di discutere dei rischi legati alla velocità del treno in un tubo isolato a bassa pressione, dei costi della manutenzione, dei problemi legati alla sicurezza dei passeggeri e delle merci, che ho letto agitano molti esperti del settore. Mi lascia invece molto dubbioso un progetto, come quello di cui leggo appunto gli annunci sulla stampa, in un Paese in cui il problema delle infrastrutture ferroviarie è ancora in larga parte la sicurezza, il divario Nord-Sud e l’inadeguatezza del servizio rispetto ai fabbisogni di trasporto di merci e persone. E in cui ancora il vero problema delle infrastrutture sono i costi inspiegabilmente maggiori che in altri Paesi. Ricordo ai lettori che in Italia il costo al kilometro dell’alta velocità era nel 2018, secondo la Corte dei Conti europea, doppio rispetto a qualunque altro Paese dell’Unione. Addirittura nel primo rapporto della Commissione Europea sulla Corruzione in EU, nel 2014, si sosteneva che i costi eccessivi dell’alta velocità in Italia (6 volte superiore al Giappone, per esempio, al tempo) non potevano essere spiegati con le peculiarità geo-morfologiche e sismiche del nostro territorio, ma, anche “alla luce di altri indicatori, di un’eventuale cattiva gestione o di irregolarità delle gare per gli appalti pubblici”. In breve, il problema di questo Paese non è fare andare i treni a velocità supersonica, ma realizzare una rete infrastrutturale veloce e affidabile senza ruberie e malaffare.
Il vero paradosso del fallimento di Hyperloop One, dunque, non è che negli States o in Italia si finanzino tecnologie rivoluzionarie (e inutili mega-strutture), ma che ancora si facciano passi incerti e spesso falsi verso reti infrastrutturali moderne ed efficienti.