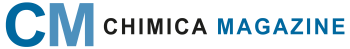15-10-2020
Traffico via mare, tra blank sailing e slow steaming
Decarbonizzazione, automazione delle infrastrutture portuali e logistiche e green financing sono invece le proposte emerse a fine settembre a Port&ShippingTech, main conference della Naples Shipping Week svoltasi a fine settembre, evento scelto da SRM – Studi e ricerche per il Mezzogiorno per presentare il settimo rapporto annuale “Italian Maritime Economy”. Lo studio analizza gli impatti della pandemia Covid-19 sul nostro sistema logistico-marittimo e i vari aspetti con cui il fenomeno si sta manifestando: accadimenti importanti come le blank sailing, lo slow steaming, la riduzione dei passaggi del Canale di Suez, la nuova configurazione dei traffici mondiali, i trend più recenti dei flussi marittimi del commercio internazionale.
Questa settima edizione è dedicata però a fornire anche una visione strategica su quali potranno essere, per il futuro, i driver e i modelli portuali che offriranno alle nostre infrastrutture più resilienza agli shock economici e sanitari come ad esempio l’intermodalità e la sostenibilità. «Mettiamo in risalto – racconta Massimo Deandreis, direttore generale SRM - come la pandemia stia cambiando la geografia delle relazioni economiche mondiali viste attraverso la lente dei traffici marittimi. Lo scontro commerciale Cina-Usa visto dalla rotta del Pacifico, il rallentamento della Belt and Road Initiative e dell’export cinese, l’impatto sul Canale di Suez e l’emergere di rotte alternative sono elementi che influenzano direttamente anche gli scenari del Mediterraneo e la portualità del nostro Paese. Siamo in una fase di regionalizzazione della globalizzazione ed emerge chiaramente l’importanza strategica di investire per una portualità e una logistica efficiente e integrata con le reti europee. L’Italia è un ponte naturale tra Europa e Sud Mediterraneo per energia e logistica. Recuperare questo ruolo è una priorità nazionale coerente con l’interesse europeo e il Recovery Fund deve essere la spinta determinante a fare quegli investimenti che si aspettano da anni».
Dal rapporto emerge che il trasporto marittimo continua a rappresentare il principale “veicolo” dello sviluppo del commercio internazionale: il 90% delle merci, infatti, viaggia via mare. Riguardo l’impatto con la pandemia, sul commercio internazionale FMI ha stimato una perdita sui volumi di circa il 12% per l’anno 2020 con un rimbalzo dell’8% nel 2021. Le ripercussioni sul segmento container (la proxy più vicina al commercio internazionale in quanto esprime per lo più il traffico manifatturiero) evidenziano un calo del 7,3% nel 2020 (742 milioni di TEU movimentati nei porti mondiali), il che riporta il traffico container ai volumi del 2017. In altre parole il virus ha portato via al settore gli ultimi quattro anni di crescita benché si intraveda un rimbalzo del 10% al 2021 e del 6,6% nel 2022. Allungando le previsioni al 2024 la movimentazione container dei porti a livello mondiale dovrebbe crescere ad un tasso medio annuo del 3,5% fino ad arrivare a 951 milioni di TEU entro il 2024. Detto questo, il Mediterraneo rappresenta ancora una via privilegiata di transito per i traffici containerizzati concentrando il 27% dei circa 500 servizi di linea mondiali via nave. Il Canale di Suez, nei primi 5 mesi del 2020, non ha più registrato le crescite sostenute (a doppia cifra) del 2019; pur registrando un aumento del 7% delle navi in transito, la presenza di containership ha registrato un calo del 15%.
La diminuzione del traffico via Suez è essenzialmente dovuta a due fattori entrambi attribuibili al Covid-19: a) calo dei carichi movimentati dalle navi; b) calo del prezzo del petrolio che ha indotto numerose portacontainer a passare per il Capo africano di Buona Speranza risparmiando i costi del pedaggio, allungando il percorso di circa 3mila miglia nautiche: sono 52 (il 5,1% del totale) le megaship che hanno preferito quest’ultima rotta nel periodo marzo-giugno 2020. Inoltre, i cambiamenti climatici stanno sempre più portando l’attenzione verso la Rotta Marittima Artica (c.d. NSR o Northern Sea Route) che ha potenzialità dovute a condizioni climatiche più agevoli ed alla possibilità di collegare i porti del Far East con quelli del Northern range da Nord. La rotta è al momento caratterizzata da traffici stagionali ed intraregionali: il 98% è SSS-Short Sea Shipping, vale a dire trasporto marittimo di corto raggio.
Traffici marittimi in Italia
Per la portualità italiana, il rapporto conferma un trend di traffico stabile negli ultimi 5 anni in Italia intorno alle 480/490 milioni di tonnellate movimentate nell’anno. In evidenza la netta prevalenza delle rinfuse liquide che coprono il 37% del totale, segue il segmento container con una quota pari al 23%, mentre il Ro-Ro si attesta al 22% e le rinfuse solide al 12%, chiudono le merci varie con circa il 5%. In Italia la componente internazionale del trasporto marittimo è sempre rilevante. Nel 2019 il valore degli scambi commerciali via mare dell’Italia è stato pari a 249,1 miliardi di euro, registrando un -1% sull’anno precedente. Di questi 129,6 miliardi di euro sono in import (-2%) e 119,5 in export (costante).
La Cina è il nostro principale Paese fornitore: con 23,1 miliardi di euro rappresenta il 18% di tutto l’import via mare italiano. Il primo Paese cliente per modalità marittima sono gli USA che con 28,1 miliardi di euro concentra il 24% del nostro export. I primi cinque Energy Port italiani (Trieste, Cagliari, Augusta, Milazzo e Genova) rappresentano il 69% dell’intero traffico liquido nazionale e Trieste, con 43,3 milioni di tonnellate, si conferma lo scalo italiano che movimenta i volumi più elevati. Seguono Cagliari ed Augusta in Sicilia. L’Italia si conferma inoltre leader nello Short Sea Shipping nel Mediterraneo: è il primo Paese nell’UE28 per trasporto di merci in modalità Short Sea Shipping (trasporto via mare a corto raggio) nel Mediterraneo, con 246 milioni di tonnellate di merci trasportate (quota di mercato 39%).
Digitalizzazione, integrazione e ZES
Fattore su cui puntare con forza, anche in prospettiva futura, è l’incentivazione al trasporto ferroviario, ritenuto più sicuro, rapido e meno soggetto a file ed attese ai controlli. Il ferro rappresenta un’opportunità da cogliere anche perché può trasportare una quantità di merce maggiore rispetto ai Tir e rappresentare il giusto raccordo per far ripartire il traffico nazionale ed internazionale. A titolo di esempio, le aziende, secondo le analisi di SRM, per raggiungere il porto e viceversa, utilizzano ancora marginalmente i collegamenti intermodali (certo anche per mancanza di infrastrutture). Per l’83% delle imprese la principale modalità di collegamento è “la strada”; il restante 17% utilizza la combinazione strada/ferrovia. Inoltre bisogna far decollare le opere immediatamente cantierabili nei porti. Prevedere un intervento sblocca-porti che agisca su un panel di infrastrutture portuali “ad alto impatto economico” SRM ha stimato, analizzando un panel di programmi operativi portuali (POT), oltre 4 miliardi di opere portuali in vari stati di avanzamento e di varia dimensione.
Sarebbe ipotizzabile riproporre l’analisi per individuare e censire quindi quali sono le opere ad alto impatto economico ed a quale stato della progettazione esse si trovino per impostare su di esse una ripartenza senza vincoli burocratici. Il Coronavirus ha messo in evidenza come due punti strategici siano, in primo luogo, quello di avviare processi di digitalizzazione delle procedure portuali e quindi di evitare quanto più possibile contatti umani (fermo restando quelli ineliminabili) e, in secondo luogo, come illustra il rapporto, puntare su integrazione infrastrutturale e quindi favorire lo sviluppo della ferrovia e dell’intermodalità; questo però richiede l’impiego di grandi risorse.
Perché allora non prevedere con i Fondi UE per il Mezzogiorno strategie mirate verso i porti del Sud e renderli ancor più competitivi? Gli scali meridionali movimentano merci per oltre il 42% del totale nazionale ed hanno l’esperienza di un territorio che utilizza il mare per il 62% del suo import-export. SRM inviata anche al rilancio immediato delle Zone Economiche Speciali e delle Zone Logistiche Semplificate per dare impulso ulteriore agli investimenti imprenditoriali. Al momento questi strumenti, pur decollati in punto procedurale, sembrano anch’essi in una fase di “stallo tecnico” per la mancanza di decreti di attuazione che rendano operativi alcuni provvedimenti sulla semplificazione amministrativa. Le ZES non sono strumenti che producono effetti nell’immediato, ma servono per aumentare la credibilità di un sistema portuale e logistico e, se ben integrati con Zone Franche portuali possono avere effetti importanti per un territorio attraverso l’esenzione di IVA e dazi per le merci extra UE e dando la possibilità di stoccare merci in magazzino in attesa della ripresa del mercato; uno stimolo al commercio internazionale non da poco.
Il rapporto integrale è scaricabile qui.
Decarbonizzazione, automazione delle infrastrutture portuali e logistiche e green financing sono invece le proposte emerse a fine settembre a Port&ShippingTech, main conference della Naples Shipping Week svoltasi a fine settembre, evento scelto da SRM – Studi e ricerche per il Mezzogiorno per presentare il settimo rapporto annuale “Italian Maritime Economy”. Lo studio analizza gli impatti della pandemia Covid-19 sul nostro sistema logistico-marittimo e i vari aspetti con cui il fenomeno si sta manifestando: accadimenti importanti come le blank sailing, lo slow steaming, la riduzione dei passaggi del Canale di Suez, la nuova configurazione dei traffici mondiali, i trend più recenti dei flussi marittimi del commercio internazionale.
Questa settima edizione è dedicata però a fornire anche una visione strategica su quali potranno essere, per il futuro, i driver e i modelli portuali che offriranno alle nostre infrastrutture più resilienza agli shock economici e sanitari come ad esempio l’intermodalità e la sostenibilità. «Mettiamo in risalto – racconta Massimo Deandreis, direttore generale SRM - come la pandemia stia cambiando la geografia delle relazioni economiche mondiali viste attraverso la lente dei traffici marittimi. Lo scontro commerciale Cina-Usa visto dalla rotta del Pacifico, il rallentamento della Belt and Road Initiative e dell’export cinese, l’impatto sul Canale di Suez e l’emergere di rotte alternative sono elementi che influenzano direttamente anche gli scenari del Mediterraneo e la portualità del nostro Paese. Siamo in una fase di regionalizzazione della globalizzazione ed emerge chiaramente l’importanza strategica di investire per una portualità e una logistica efficiente e integrata con le reti europee. L’Italia è un ponte naturale tra Europa e Sud Mediterraneo per energia e logistica. Recuperare questo ruolo è una priorità nazionale coerente con l’interesse europeo e il Recovery Fund deve essere la spinta determinante a fare quegli investimenti che si aspettano da anni».
Dal rapporto emerge che il trasporto marittimo continua a rappresentare il principale “veicolo” dello sviluppo del commercio internazionale: il 90% delle merci, infatti, viaggia via mare. Riguardo l’impatto con la pandemia, sul commercio internazionale FMI ha stimato una perdita sui volumi di circa il 12% per l’anno 2020 con un rimbalzo dell’8% nel 2021. Le ripercussioni sul segmento container (la proxy più vicina al commercio internazionale in quanto esprime per lo più il traffico manifatturiero) evidenziano un calo del 7,3% nel 2020 (742 milioni di TEU movimentati nei porti mondiali), il che riporta il traffico container ai volumi del 2017. In altre parole il virus ha portato via al settore gli ultimi quattro anni di crescita benché si intraveda un rimbalzo del 10% al 2021 e del 6,6% nel 2022. Allungando le previsioni al 2024 la movimentazione container dei porti a livello mondiale dovrebbe crescere ad un tasso medio annuo del 3,5% fino ad arrivare a 951 milioni di TEU entro il 2024. Detto questo, il Mediterraneo rappresenta ancora una via privilegiata di transito per i traffici containerizzati concentrando il 27% dei circa 500 servizi di linea mondiali via nave. Il Canale di Suez, nei primi 5 mesi del 2020, non ha più registrato le crescite sostenute (a doppia cifra) del 2019; pur registrando un aumento del 7% delle navi in transito, la presenza di containership ha registrato un calo del 15%.
La diminuzione del traffico via Suez è essenzialmente dovuta a due fattori entrambi attribuibili al Covid-19: a) calo dei carichi movimentati dalle navi; b) calo del prezzo del petrolio che ha indotto numerose portacontainer a passare per il Capo africano di Buona Speranza risparmiando i costi del pedaggio, allungando il percorso di circa 3mila miglia nautiche: sono 52 (il 5,1% del totale) le megaship che hanno preferito quest’ultima rotta nel periodo marzo-giugno 2020. Inoltre, i cambiamenti climatici stanno sempre più portando l’attenzione verso la Rotta Marittima Artica (c.d. NSR o Northern Sea Route) che ha potenzialità dovute a condizioni climatiche più agevoli ed alla possibilità di collegare i porti del Far East con quelli del Northern range da Nord. La rotta è al momento caratterizzata da traffici stagionali ed intraregionali: il 98% è SSS-Short Sea Shipping, vale a dire trasporto marittimo di corto raggio.
Traffici marittimi in Italia
Per la portualità italiana, il rapporto conferma un trend di traffico stabile negli ultimi 5 anni in Italia intorno alle 480/490 milioni di tonnellate movimentate nell’anno. In evidenza la netta prevalenza delle rinfuse liquide che coprono il 37% del totale, segue il segmento container con una quota pari al 23%, mentre il Ro-Ro si attesta al 22% e le rinfuse solide al 12%, chiudono le merci varie con circa il 5%. In Italia la componente internazionale del trasporto marittimo è sempre rilevante. Nel 2019 il valore degli scambi commerciali via mare dell’Italia è stato pari a 249,1 miliardi di euro, registrando un -1% sull’anno precedente. Di questi 129,6 miliardi di euro sono in import (-2%) e 119,5 in export (costante).
La Cina è il nostro principale Paese fornitore: con 23,1 miliardi di euro rappresenta il 18% di tutto l’import via mare italiano. Il primo Paese cliente per modalità marittima sono gli USA che con 28,1 miliardi di euro concentra il 24% del nostro export. I primi cinque Energy Port italiani (Trieste, Cagliari, Augusta, Milazzo e Genova) rappresentano il 69% dell’intero traffico liquido nazionale e Trieste, con 43,3 milioni di tonnellate, si conferma lo scalo italiano che movimenta i volumi più elevati. Seguono Cagliari ed Augusta in Sicilia. L’Italia si conferma inoltre leader nello Short Sea Shipping nel Mediterraneo: è il primo Paese nell’UE28 per trasporto di merci in modalità Short Sea Shipping (trasporto via mare a corto raggio) nel Mediterraneo, con 246 milioni di tonnellate di merci trasportate (quota di mercato 39%).
Digitalizzazione, integrazione e ZES
Fattore su cui puntare con forza, anche in prospettiva futura, è l’incentivazione al trasporto ferroviario, ritenuto più sicuro, rapido e meno soggetto a file ed attese ai controlli. Il ferro rappresenta un’opportunità da cogliere anche perché può trasportare una quantità di merce maggiore rispetto ai Tir e rappresentare il giusto raccordo per far ripartire il traffico nazionale ed internazionale. A titolo di esempio, le aziende, secondo le analisi di SRM, per raggiungere il porto e viceversa, utilizzano ancora marginalmente i collegamenti intermodali (certo anche per mancanza di infrastrutture). Per l’83% delle imprese la principale modalità di collegamento è “la strada”; il restante 17% utilizza la combinazione strada/ferrovia. Inoltre bisogna far decollare le opere immediatamente cantierabili nei porti. Prevedere un intervento sblocca-porti che agisca su un panel di infrastrutture portuali “ad alto impatto economico” SRM ha stimato, analizzando un panel di programmi operativi portuali (POT), oltre 4 miliardi di opere portuali in vari stati di avanzamento e di varia dimensione.
Sarebbe ipotizzabile riproporre l’analisi per individuare e censire quindi quali sono le opere ad alto impatto economico ed a quale stato della progettazione esse si trovino per impostare su di esse una ripartenza senza vincoli burocratici. Il Coronavirus ha messo in evidenza come due punti strategici siano, in primo luogo, quello di avviare processi di digitalizzazione delle procedure portuali e quindi di evitare quanto più possibile contatti umani (fermo restando quelli ineliminabili) e, in secondo luogo, come illustra il rapporto, puntare su integrazione infrastrutturale e quindi favorire lo sviluppo della ferrovia e dell’intermodalità; questo però richiede l’impiego di grandi risorse.
Perché allora non prevedere con i Fondi UE per il Mezzogiorno strategie mirate verso i porti del Sud e renderli ancor più competitivi? Gli scali meridionali movimentano merci per oltre il 42% del totale nazionale ed hanno l’esperienza di un territorio che utilizza il mare per il 62% del suo import-export. SRM inviata anche al rilancio immediato delle Zone Economiche Speciali e delle Zone Logistiche Semplificate per dare impulso ulteriore agli investimenti imprenditoriali. Al momento questi strumenti, pur decollati in punto procedurale, sembrano anch’essi in una fase di “stallo tecnico” per la mancanza di decreti di attuazione che rendano operativi alcuni provvedimenti sulla semplificazione amministrativa. Le ZES non sono strumenti che producono effetti nell’immediato, ma servono per aumentare la credibilità di un sistema portuale e logistico e, se ben integrati con Zone Franche portuali possono avere effetti importanti per un territorio attraverso l’esenzione di IVA e dazi per le merci extra UE e dando la possibilità di stoccare merci in magazzino in attesa della ripresa del mercato; uno stimolo al commercio internazionale non da poco.
Il rapporto integrale è scaricabile qui.